Una volta durante una cerimonia allo Zen Center, uno studente chiese all'abbate: "Che cosa mi può insegnare il Dharma sul servizio per gli altri?"
L'abbate rispose: "Quali altri? Servi te stesso!"
Ma lo studente insistette: "Come faccio a servire me stesso?" Al che la risposta dell'abbate fu: "Prenditi cura degli altri".
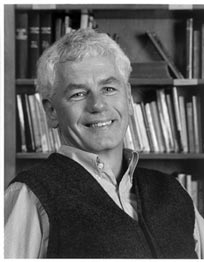 Ogni giorno lavoro vicino a persone
che stanno per morire e tra loro
ce ne sono alcune difficili da
trattare. Può darsi che
abbiano vissuto per periodi più
o meno lunghi da barboni o che
siano amareggiati per aver perso
il controllo sulle loro vite.
Spesso hanno perso fiducia nell'umanità:
girano la testa contro il muro
e si ritirano in se stessi. Il
buddhislmo non interessa assolutamente
nulla alla maggior parte di loro.
Persone di questo genere non si
fidano facilmente e se voglio
essere di qualche utilità
dovrò essere estremamente
chiaro e onesto circa la mia intenzione,
in caso contrario non gli ci vorrà
molto per indovinare la mia ipocrisia
e il mio sentimentalismo.
Ogni giorno lavoro vicino a persone
che stanno per morire e tra loro
ce ne sono alcune difficili da
trattare. Può darsi che
abbiano vissuto per periodi più
o meno lunghi da barboni o che
siano amareggiati per aver perso
il controllo sulle loro vite.
Spesso hanno perso fiducia nell'umanità:
girano la testa contro il muro
e si ritirano in se stessi. Il
buddhislmo non interessa assolutamente
nulla alla maggior parte di loro.
Persone di questo genere non si
fidano facilmente e se voglio
essere di qualche utilità
dovrò essere estremamente
chiaro e onesto circa la mia intenzione,
in caso contrario non gli ci vorrà
molto per indovinare la mia ipocrisia
e il mio sentimentalismo. Alcuni tra loro, però, incontrano una vera fioritura e il modo in cui muoiono è un grande dono: si riconciliano con parenti che avevano perso da tempo e scoprono finalmente la gentilezza e l'accettazione che avevano cercato tutta la vita. Trovarsi vicino a persone simili può essere un'esperienza straordinaria. Ma non faccio questo lavoro per trovarmi in momenti simili: inseguire ricompense di questo genere porta all'esaurimento e alla fine si finisce per diventare manipolativi perché si è troppo presi dal tentativo di creare le condizioni che portano a tali esiti. Ed è così che non si coglie la situazione concreta.
A me piace svolgere questo lavoro perché è un servizio anche per me. Cerco sempre di vedermi nelle persone che assisto e di vedere loro in me. Essi lo sanno e perciò si fidano e riescono ad avere fiducia in questo genere di lavoro; capiscono che lo stiamo facendo insieme.
Prendersi cura dell'altro è sempre di beneficio reciproco. Prendendoci cura degli altri, ci prendiamo cura anche di noi stessi e una tale comprensione cambia in maniera radicale il modo in cui prestiamo assistenza. Non sono il buono che viene a salvare: non ho nessun cavallo bianco!
Piuttosto diventiamo insieme quelli che io chiamo "compagni nella compassione"; tradotta letteralmente 'compassione' significa soffrire con gli altri e quel 'con' è la parola più importante perché implica appartenenza. 'Compagno' indica 'uno che viaggia con un altro'. Abbiamo allora un rapporto dove non c'è nessuna guida, dove non c'è nessuno che guarisce e nessuno che viene guarito, dove ci accompagniamo semplicemente a vicenda. Come dice il mio amico Reb Anderson: "Stiamo semplicemente camminando mano nella mano attraverso la nascita e la morte".
Se entriamo con attenzione nella stanza di una persona che sta morendo, capiremo al volo, in modo viscerale, quanto sia precaria la vita. Ma nel capire questo, realizzeremo anche quanto sia preziosa. Con la morte così vicina e a portata di mano, diventiamo meno compulsivi nei confronti dei nostri desideri e prendiamo meno sul serio noi stessi e le nostre idee, diventiamo capaci di lasciare andare con più facilità. Ci apriamo di più alla generosità e all'amore. Paradossalmente il lavorare con i morenti ci renderà più gentili gli uni con gli altri. Davanti alla morte tutto ciò con cui normalmente ci identifichiamo viene strappato via dalla malattia o reso con grazia, ma comunque tutto va via. "Sono un padre, "Sono una madre", "Sono un assistente in un hospice", "Sono un omosessuale": qualunque sia la nozione che abbiamo di noi stessi, andrà via.
In superficie, le vite delle persone accanto a cui lavoro sembrano molto diverse dalla mia: in genere sono neri mentre io sono bianco, spesso si tratta di persone che si iniettano eroina e hanno l'AIDS e io no, sono soli e senza una casa mentre io pago un affitto abbastanza alto e ho quattro figli adolescenti. Sarebbe facile per me convincermi che siamo separati: in fondo solo qualche mese fa incontrandoci per strada ci saremmo ignorati. Ma la cosa straordinaria è che adesso nell'hospice ci troviamo insieme nella più intima delle circostanze. E capita che nel bel mezzo dell'attività, in dettagli del servizio, improvvisamente troviamo un punto di incontro e scopriamo allora di appartenere uno all'altro.
Prima di qualsiasi atto del pensiero o della parola c'è un momento di intenzione di cui dobbiamo essere consapevoli. La chiarezza sull'intenzione ci permette di scegliere come procedere: basta un momento di contatto con l'intenzione per rompere i nostri schemi abituali e per fermarci dall'agire come se avessimo inserito un pilota automatico.
Nella tradizione Zen esiste la pratica del 'dokusan', ossia del colloquio con l'insegnante. Al praticante viene detto di aspettare fuori dalla porta del maestro e di raccogliersi completamente nel momento presente. Non ha idea di che cosa lo aspetti dall'altra parte della porta e di che cosa gli questi gli chiederà, dovrà dunque restare pronto, flessibile e aperto. Entrare nella stanza di un paziente che sta morendo, è come andare per un dokusan. Idealmente il nostro corpo e la nostra mente dovrebbero entrare nella stanza nello stesso momento, ma a volte non va affatto così. Co può capitare di lasciare la mente molto indietro - a volte lasciamo anche il nostro corpo indietro! Oppure entriamo nella stanza molti giorni prima di entrarci realmente.
Una volta a un volontario che conosco capitò proprio questo: si recò al letto di un paziente che lo accolse con gioia e gli disse: "Oh, sono davvero contento che sei venuto, finalmente ho qualcuno con cui poter parlare della mia morte". Lui si sentì soddisfatto e rispose: "Sì, certo, ti porterò dei libri della Kübler Ross e di Stephen Levine. Tornerò la settimana prossima e ne parleremo insieme". La settimana successiva tornò con un mucchio di libri, ma il paziente gli disse: "Grazie, ma adesso c'è la partita in TV, siediti e guardiamola insieme".
Troppo spesso nel lavoro di assistenza, non guardiamo tanto a ciò che realmente serve, quanto piuttosto cerchiamo una conferma al alcune idee che abbiamo su noi stessi. Vogliamo essere qualcuno, diciamo: "Io lavoro con i morenti" e mettiamo l'enfasi su quell''io', investendo più nel ruolo che nella funzione. Io la chiamo "la malattia di chi aiuta" ed è un'epidemia molto più diffusa dell'AIDS o del cancro. In realtà stiamo cercando di separarci dalla sofferenza dell'altro e lo facciamo utilizzando la nostra pietà, la nostra paura, il nostro calore professionale o anche attraverso dei gesti caritatevoli. Ma tutto ciò non ha niente a che fare con la carità.
Qualche anno fa, nel nostro hospice ricordo una donna molto triste e depressa che sarebbe poi morta pochi giorni dopo. A me sembrava naturale il suo stato d'animo visto che stava per morire. Ma un'infermiera suggerì di darle dell'Elavil che è un farmaco usato per migliorare l'umore e che, però, ha bisogno di venti giorni prima di fare effetto. Chiesi a quell'infermiera perché mai volesse darlo. Mi rispose: "Quella donna sta soffrendo ed è così difficile vederla soffrire". Al che le dissi che forse era il caso che prendesse lei l'Elavil.
L'attaccamento al ruolo di colui che aiuta è una storia vecchia per quasi tutti noi. Aiutare gli altri dà un senso di potere o rispettabilità che a fine settimana passiamo a ritirare come se fosse uno stipendio!
Se non stiamo attenti, però, questa identità finirà per imprigionare sia noi che coloro che aiutiamo. In fondo, se sono uno che aiuta, vi dovrà pure essere qualcuno che ha bisogno di aiuto!
La mia amica Rachel Remen che dirige il Centro per i Tumori in California descrive molto bene questa situazione. Sostiene che il servizio non è la stessa cosa del dare aiuto. L'aiutare si basa sulla disuguaglianza, non è una relazione tra uguali. Quando si aiuta si usa la propria forza per aiutare qualcuno che ne ha meno. E' un rapporto in cui uno sta sopra e l'altro sotto; le persone avvertono questa disparità. A volte, senza volerlo, togliamo piuttosto che dare, sminuendo in questo modo il senso di auto stima e valore della persona. Quando aiuto sono molto consapevole della mia forza, mentre non serviamo con la forza, bensì con noi stessi.
Abbiamo bisogno di tutte le nostre esperienze: ci servono le nostre ferite, i nostri limiti e anche la nostra oscurità. L'interezza in noi serve l'interezza nell'altro e nella vita. Aiutare significa creare un debito: quando aiuti qualcuno questi diventa tuo debitore. Il servizio, invece, è reciproco. Nell'aiuto proviamo una sensazione di soddisfazione, nel servizio un sentimento di gratitudine. Servire è anche diverso da riparare, si riparano dei tubi rotti, non le persone. Quando mi metto a riparare un'altra persona lo faccio perché la vedo come rotta; è una forma di giudizio che ci separa e che crea distanza.
Aiutare, riparare e servire sono modi diversi di vedere la vita, quando si aiuta ce la rappresentiamo debole, quando si ripara la si considera rotta mentre nel servizio la vita è vista nella sua interezza. E allora possiamo capire che la sofferenza dell'altro è anche la mia, così come la sua gioia. Allora la spinta al servizio nascerà con naturalezza e la nostra naturale saggezza e compassione si manifesteranno con semplicità.
Chi pratica il servizio sa di venire usato ed è disponibile ad esserlo per qualcosa di più importante. Possiamo aiutare o riparare molte cose nella nostra vita, ma nel servizio siamo sempre al servizio dell'interezza.
Stare vicino a chi soffre, non importa se in fin di vita o meno, ci risveglia e apre i nostri cuori e le nostre menti; ci apre all'esperienza dell'unità. Spesso però veniamo catturati nei nostri ruoli abituali e nelle idee che ci tengono separati gli uni dagli altri.
Persi in uno stato mentale reattivo, occupati nel tentativo di proteggere l'immagine che abbiamo di noi stessi, ci tagliamo fuori e ci isoliamo da ciò che veramente servirebbe e ispirerebbe il nostro lavoro. Per essere persone che guariscono dobbiamo essere disponibili a portare al capezzale la nostra passione insieme alle ferite della nostra paura e a tutto ciò che siamo. Infatti, è proprio l'esplorazione della nostra sofferenza che costituisce un ponte con le persone che stiamo servendo.
Qualche anno fa un mio carissimo amico a cui volevo molto bene si ammalò con l'AIDS, lo conoscevo da molti anni. Nello stesso pomeriggio perse la capacità di parlare, di reggere una forchetta, di stare in piedi e di formulare una frase in modo coerente e tutto ciò accadde proprio un pomeriggio in cui c'ero io ad assisterlo. Mi spaventai a morte: "Come? Io, il signor Hospice!"
Feci tutto ciò che potevo per prendermi cura di lui. Aveva delle fistole enormi, dei tumori anali e una diarrea costante. Ci spostavamo continuamente avanti e indietro dal gabinetto alla vasca. Andò avanti così tutta la notte. Ero sfinito e desideravo solamente metterlo a letto per poter dormire anch'io un po'. Provai con ogni trucco che conoscevo, provai a essere persuasivo, manipolativo, paternalista: quella notte cambiai abito più spesso di Madonna. Nel bel mezzo di uno di questi spostamenti dal water alla vasca mi parlò e dalla sua mente confusa uscirono queste parole: "Ti stai sforzando troppo". Era vero, mi fermai e mi misi a sedere accanto al water iniziando a piangere. Fu quello l'incontro più intenso di tutto il nostro rapporto. Eravamo insieme, completamente indifesi, senza separazione o ruoli professionali.
Se non siamo disposti a esplorare la nostra sofferenza, allora nel cercare di capire i pazienti faremo solo dei salti al buio. E' l'esplorazione della nostra sofferenza che ci permette di servire gli altri e di toccarne il dolore con compassione invece che con paura e pietà. Dobbiamo avere la volontà di ascoltare non solo il paziente, ma anche noi stessi. Dobbiamo prestare molta attenzione a ciò che incontriamo immediatamente davanti a noi.
Circa un anno fa, un'anziana donna ebrea russa, un tipo duro, stava in fase terminale. Quando entrai nella sua camera vidi che respirava con grande difficoltà e la persona che l'assisteva seduto lì accanto le disse: "Non deve aver paura, ci sono io qui con lei". Al che la donna replicò: "Mi creda, se si trovasse nella mia situazione, anche lei avrebbe paura". Dopo un po' l'assistente disse: "Mi sembra che abbia freddo, vuole una coperta?" La donna rispose: "Certo che ho freddo, sono quasi morta". Per aiutarla veramente, sapevo che dovevo ascoltare, dovevo veramente prestare attenzione a ciò che stava dicendo.
Stava lottando con il respiro, ma voleva essere trattata con onestà, non voleva sentire stupidaggini. Le dissi: "Adèle, vorresti soffrire un po' meno? Combattere un po' meno?"
"Sì".
"Ho visto che c'è un piccolo posto proprio lì, tra l'inspirazione e l'espirazione, dove riposi. Riesci anche solo per un attimo a portare l'attenzione proprio in quel punto?"
Ricordate? Si trattava di un'ebrea russa, alquanto dura, assolutamente priva di interesse per il buddhismo o la meditazione. Ma voleva lottare meno e così per alcuni minuti si impegnò e mentre lo faceva vidi sul suo viso che la paura iniziava a scomparire. Dopo pochi altri respiri morì in tutta tranquillità.
Se vogliamo prestare servizio, dobbiamo esseri attenti a ciò che ci si presenta davanti e agire con il minimo intervento possibile, portando nella situazione la stessa attenzione ed equanimità che coltiviamo sul cuscino di meditazione.
La misura della nostra abilità nel servizio è data dal grado di disponibilità e capacità che abbiamo di vivere il momento presente con immutata freschezza. Quando il cuore è aperto e la mente è tranquilla, quando la nostra attenzione è tutta nel momento presente, allora il mondo ci appare non più diviso e noi sappiamo che cosa fare.
Tutti possiamo riuscirci, non c'è bisogno di vent'anni di pratica buddhista. Ciascuno ha la capacità dentro di sé di abbracciare la sofferenza dell'altro come se fosse la propria. Lo facciamo da centinaia di anni, abbiamo solo dimenticato e così abbiamo bisogno di ricordarcene.
Una volta, quando il nostro hospice aveva appena iniziato a funzionare, accadde che un uomo con l'AIDS cadde mentre uno dei volontari lo stava aiutando a spostarsi dal letto al comodino. Successe di tutto!
I pantaloni gli caddero giù fino alle caviglie e il mobiletto si rovesciò, la stanza era una piccola Hiroshima! In effetti il lavoro di assistenza è proprio così. Comunque Tom riuscì, sia pure goffamente, a rimettere il paziente sul letto, dopodiché mi telefonò: "Frank, vorrei che ripassassimo insieme le tecniche che abbiamo studiato al corso per mettere le persone a letto".
"Va bene" risposi "ma ora fai così: la prossima volta che devi spostare J. D., prima di iniziare, controlla un attimo la tua pancia, guarda se è morbida. Se non lo è, non fare nulla".
"Non cominciare con queste storie buddhiste. Voglio solo sapere che cosa devo fare con le sue ginocchia".
"Controlla la tua pancia, e poi richiamami". Era come dire: "Prendi due aspirine e chiamami domani mattina". Invece mi richiamò poco dopo.
"Frank, è stata una cosa incredibile: sono andato per spostare J. D. e la mia pancia era dura come un sasso, allora mi sono fermato. Ho fatto alcuni respiri, la mia pancia si è ammorbidita e subito mi sono ritrovato J. D. tra le braccia, come un'amante o un bambino piccolo. Non è stato difficile".
Tutti sappiamo come farlo.
La pratica buddhista comprende la nozione che siamo tutti già nati molte altre volte precedentemente e che siamo stati tutti madri, padri e figli l'uno dell'altro. Dovremmo trattare quindi ogni persona che incontriamo come se fosse un nostro caro.
Se indaghiamo al cuore del servizio, vediamo che c'è uno schema che si ripete: il senso di separatezza è il comun denominatore di tutte le abitudini che ci ostacolano nel nostro lavoro, mentre l'esperienza dell'unità è sempre presente in ogni gesto o momento che sembrano andare nella direzione del servizio.
Einstein ha parlato di questo e Sogyal Rinpoche lo cita nel suo "Il libro tibetano del vivere e del morire":
"Ogni essere umano fa parte di un insieme, che noi chiamiamo l''Universo', una parte limitata nel tempo e nello spazio. L'uomo vive se stesso, i suoi pensieri e sentimenti come qualcosa di separato da tutto il resto, in una specie di illusione ottica della sua coscienza. L'illusione costituisce una sorta di prigione che ci limita ai nostri desideri personali e all'affetto per le poche persone più vicine a noi. Il nostro compito deve essere quello di liberarci da questa prigione, allargando il nostro cerchio di compassione fino ad abbracciare tutte le creature viventi e l'intera natura nella sua bellezza".
Quando il cuore non è più diviso, tutto ciò che incontriamo diventa la nostra pratica ed ecco che, allora, il servizio è uno scambio sacro, proprio come inspirare ed espirare. Il sostegno fisico e spirituale che riceviamo nel mondo equivale all'inspirazione. Poi, poiché tutti abbiamo dei doni da offrire, una parte della nostra felicità nel mondo consiste nel restituire qualcosa e questo processo equivale all'espirazione.
A un mio amico piace parlare di 'gentilezza semplice e umana". Secondo me, il nostro lavoro consiste nel non ostacolare la saggezza e la compassione innate - la gentilezza semplice e umana, appunto - e permettere alla nostra innata capacità di vedere ciò di cui ha bisogno l'altro, di porsi al servizio sia dei morenti che dei vivi.